Due giovani donne con tute infangate, stivali e guanti di lattice esaminano un cadavere trovato nel bosco in cerca di mosche o radici di piante. Non siamo sul set di CSI, ma a Milano, tra le file ordinate di faggi della periferia: qui Cristina Cattaneo e Monica Maldarella, le “signore omicidi" del Labanof (il Laboratorio di antropologia forense dell'Istituto di medicina legale dell'Università degli Studi di Milano), hanno appena raccolto insetti e piante per dare un nome a un corpo senza vita e scoprire come e quando è morto.
Cristina Cattaneo, antropologo forense e medico legale, è la direttrice del Labanof. Monica Maldarella è una naturalista, che ha cominciato con una tesi sulle "dita dei morti”: «Per la precisione», spiega, «sui metodi di rilevazione delle impronte digitali nei cadaveri in cattivo stato di conservazione». Nel 2006 hanno scritto Crimini e farfalle (Raffaello Cortina editore, pagg. 250, 19 euro), dove raccontano storie apparentemente insolubili svelate grazie a un polline, a una foglia d'acero, a una larva, a un minuscolo plancton, rinvenuti dentro il cadavere o accanto a esso.
Le incontriamo nel loro ufficio, una stanzetta al secondo piano dell'Istituto di medicina legale: sulle pareti, foglie in bacheca e insetti infilzati con spilli a tavolette di sughero, qua e là calchi di piedi umani, pezzi di cranio, volti di morti ricostruiti con la plastilina. Nei telefilm siamo abituati a vedere uomini e donne della Scientifica con tute immacolate che spolverano ambienti in cerca di impronte o svelano macchie di sangue col «luminol». Il loro sembra un lavoro più sporco, nel senso letterale della parola.


Cristina Cattaneo e Monica Maldarella del Labanof di Milano
«Quando il cadavere è ben conservato e il delitto s'è svolto in appartamento, il medico legale stabilisce data, causa della morte e identità della vittima sul lettino dell'obitorio, come nei telefilm. Ma tanti corpi vengono rinvenuti in un lago o in un bosco, magari carbonizzati e ridotti a un mucchietto d'ossa. In quei casi si deve lavorare in mezzo alla terra, con piccone e cazzuola».
Come si opera su una scena del crimine all'aperto?
«Durante il sopralluogo si cercano e si prelevano - sul cadavere e attorno - tutti gli elementi naturali utili ai vari esperti: una radice che attraversa un cranio servirà al botanico per determinare l'epoca della morte contando gli anelli annuali di accrescimento. Eventuali larve di mosche finiranno tra le mani di un entomologo: studiandole, capirà quando è avvenuto il decesso. Per lo zoologo potrebbe rivelarsi prezioso anche un pelo di gatto: magari appartiene al micio che vive col sospetto assassino».
Ma che cosa c'entrano le larve di mosca con la data di un omicidio?
«Se il cadavere è "fresco", il medico legale stabilisce quando è morto misurandagli la temperatura. Man mano che col tempo si decompone, invece, la soluzione è studiare larve e insetti che si nutrono della salma per determinare il loro stadio di accrescimento. Ad esempio, il ciclo di vita delle mosche verdi - le più comuni sui cadaveri - comprende 5 fasi: l'uovo, lungo 2 millimetri; tre stadi larvali, in cui l'insetto cresce da 10 fino a 17 millimetri di lunghezza; la pupa e lo stadio adulto. La durata del ciclo varia da una a sei settimane, a seconda delle diverse specie e delle condizioni ambientali: in piena estate, quando fa caldo, il ciclo è più breve, mentre a temperature più basse lo stadio è rallentato».
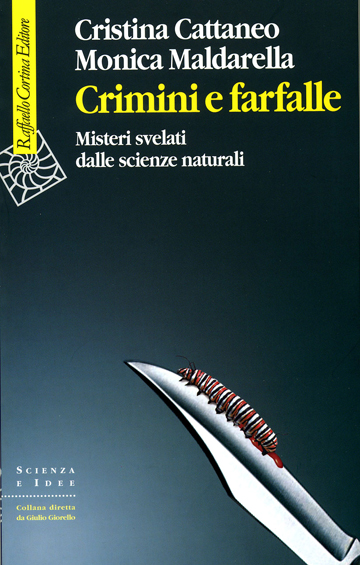
In che modo le foglie possono incastrare un assassino?
«Nell'autunno 2001 una giovane donna si suicidò dopo aver subito una violenza sessuale. Durante l'autopsia fu trovato all'interno dei suoi slip, in contatto con il pube, un pezzetto di foglia marcia. Il magistrato ci chiese se la foglia era compatibile con quelle degli alberi vicini a una baracca dove abitavano due individui sospettati. Lo studio botanico accertò che si trattava di una foglia di Celtis australis, nota come bagolaro: quella pianta si trovava proprio fuori dalla baracca. La fogliolina marcia fu un ulteriore indizio contro i due che, alla fine, confessarono».
In Crimini e farfalle parlate dell'importanza della zoologia. Con aneddoti come quello dell'uomo sospettato di aver ucciso la moglie: i poliziotti, trovando sepolti nel giardino di casa sua minuscoli frammenti di ossa carbonizzate, pensarono d'aver scoperto i resti della donna. Quelle ossa, invece, appartenevano a un maiale.
«Solo uno zoologo, dall'analisi della sezione ossea, riuscì a provare la verità. Gli esperti di zoologia, poi, svelano in un corpo le lesioni che non sono provocate da coltelli o altre armi da taglio, ma dai denti di topi, volpi, cani, gatti e persino orsi. Fattori ambientali e animali possono asportare oltre la metà del corpo originale: è stato segnalato il caso di un uccello che aveva utilizzato un cranio a mo' di nido, scegliendo per ingresso il foro occipitale».
Un tempo l'antropologo forense misurava le dimensioni delle ossa con il calibro, oggi analizza resti scheletrici con mezzi che vanno dalla microscopia all'indagine biomolecolare.
«Nell'ottobre 2001 venne rinvenuto in un bosco uno scheletro sepolto a una profondità di 20 centimetri. L’autorità giudiziaria ci chiese aiuto per stabilire l'identità e le cause della morte. Iniziammo le indagini antropologiche. La conformazione del cranio e del bacino indicavano un soggetto di sesso femminile. Dal pube capimmo che l'età oscillava tra i 20 e i 25 anni. Analisi successive dimostrarono che il soggetto, alto un metro e 65, era privo degli incisivi laterali superiori. Durante la ricostruzione facciale decidemmo di dare al volto un'espressione sorridente, proprio per mostrare la particolare dentatura. L’identikit venne diffuso e, grazie a “Chi l'ha visto?”, la donna fu identificata. Era una kosovara costretta a prostituirsi».
Nel caso di un cadavere trovato in acqua, come si possono scoprire data e causa della morte?
«Alcuni anni fa nel lago di Garda, a 70 metri di profondità, fu trovato un cadavere che battezzammo Nemo. Il capo del tutto scheletrizzato tranne collo e guance, le braccia ridotte a ossa, le mani e gli avambracci scomparsi. Uniche zone intatte le cosce e le gambe, di colore giallo-grigiastro. Nessun elemento che potesse dare informazioni sulla sua identità, come per tanti altri che arrivano in laboratorio: in media 50 all'anno, di cui 5 o 6 rinvenuti all'aperto. Addosso a quei resti, però, era presente la storia degli organismi che si erano avvicendati attorno a lui nel corso della sua lunga vita in acqua. Le maglie sfilacciate degli indumenti si intrecciavano a gusci di molluschi, a piante, a piccoli invertebrati. Ma quando si ha a che fare con corpi rinvenuti in acqua, le forme viventi più affascinanti sono le diatomee, alghe minuscole, unicellulari. Trovare le diatomee solo nei polmoni non è sinonimo di annegamento, perche possono introdursi dopo il decesso. Ma trovarle anche nel cuore e nel midollo osseo, come nel caso di Nemo, fa sospettare che siano entrate nel circolo sanguigno quando la persona era ancora in vita. Grazie alle diatomee abbiamo offerto all'Autorità giudiziaria un'ipotesi sulla causa di morte: Nemo, probabilmente un cinquantenne depresso scomparso cinque anni prima nella zona del Garda, era morto annegato. Nessuno potrà mai dire con certezza, però, se si sia trattato di suicidio o di omicidio. Anche la biologia ha i suoi limiti».
www.labanof.unimi.it